“Tutto ciò che ci affascina nel mondo inanimato, i boschi, le pianure, i fiumi, le montagne, i mari, le valli, le steppe, di più, di più, le città, i palazzi, le pietre, di più, il cielo, i tramonti, le tempeste, di più, la neve, di più, la notte, le stelle, il vento, tutte queste cose, di per sé vuote e indifferenti, si caricano di significato umano perché, senza che noi lo sospettiamo, contengono un presentimento d’amore“.
– Dino Buzzati, Un amore
L’aria è aspra come se un plotone di muschi selvatici avesse nidificato tra gli interstizi del pulviscolo. Forme di ordinaria mimesi e parassitismo si instaurano dentro e fuori di me: piante rampicanti sulle pareti rugose di questo luogo bucolico; pensieri aggrovigliati tra i miei capelli, che affollano quella stanza chiusa dall’interno che è la mia testa. La mia felice reclusione non ha radici profonde e al primo lampeggiare del cielo mi lascia orfana di quell’orgoglioso eremitaggio primordiale. A penzoloni e scalza rimugino su un senso di libertà negato, su un invito forzato alla lentezza, capace di atrofizzare persino il mio corpo disobbediente. L’atmosfera è rarefatta, carica di elettricità: sta arrivando la tempesta. Mai come oggi mi appare odiosa la mia condizione di isolano irraggiungibile; provo a ossigenare i pensieri, a sciogliere i nodi, recuperando l’autarchica semplicità della terra. Da buona sacerdotessa allestisco il mio altare, pronto per la liturgia laica: farina, acqua e lievito madre. Mi ripeto che l’unico modo per addomesticare la confusione che sento è usare le mani. La dimensione salvifica del rituale si articola inconsapevolmente, è strategia di controllo che aiuta a districare gli affanni, a dare ordine e ritmo al caos. Come monade trincerata nella sua incomunicabilità, impasto concentrata. Le mani intrecciano preghiere, indossano una gestualità matriarcale che riverbera la sacralità di un rito magico. Non c’è timidezza nei movimenti riemersi: mi sento goffa, furiosa nell’imprimere la mia forma in quella pagnotta che albeggia. Basterà a salvarmi? Tutto mi sembra più allineato: più dolce è il conflitto tra la campagna, che si pavoneggia del suo anarchico fiorire, e la memoria della città resa ostaggio di una stasi indesiderata. Un rumore di cocci frantumati arriva cieco: un vaso, una caraffa, una richiesta di soccorso, una distrazione che ora acquista l’unicità di variare il corso della giornata. Un colpo che annuncia il coprifuoco, il tremore che precede un terremoto. È un’epifanica incursione che ammonisce la solitudine della mia cerimonia e mi restituisce l’urgenza delle cose interrotte. Ringrazio quel sacrificio che punisce la convinzione di sentirmi ai bordi del mondo, che rende frustrato il mio desiderio di controllo. Quel rumore consolatorio mi ridesta dal torpore, mi risveglia dal sonno indifferente, porta in sé il miracolo di una gestazione: rinasco nella realtà, rispondo al richiamo delle altre esistenze. Mi accorgo paralizzata, con le mani infarinate secche nel loro candore. Ritorno al mio esercizio benedetto, alla mia danza apotropaica, che ora amplifica i sensi e li rende più acuti. Nel pane c’è il peso del mio corpo avviluppato a mille altri corpi e l’impasto si nutre della realtà che penso: nuoto e sogno di incontrare una mano che mi porta a trasmigrare lontano, verso la città. Chissà cosa è rimasto lì. I veri resilienti, mi dico. Gli alberi uniti in abbracci ribelli che si amano indisturbati, i fiori in assembramenti agli angoli dei marciapiedi, le imposte schiuse e le luci dei condomini come atti di resistenza al nulla che incombe fuori. Tutto esiste ancora, assottigliato e rimpicciolito. Tutti giocano a nascondino, ognuno nella propria casa, in cui abitanti e spiriti si dividono la cena. Tutti combattono la propria battaglia con il limite, con i chilometri che sentiamo di avere contro. E ora capisco: è un gioco di riconciliazione, dove la mancanza del contatto trova pace.
Mi interrompo, ha smesso di piovere: il pane chiede pietà e ha bisogno di riposare. Ora devo solo aspettare.
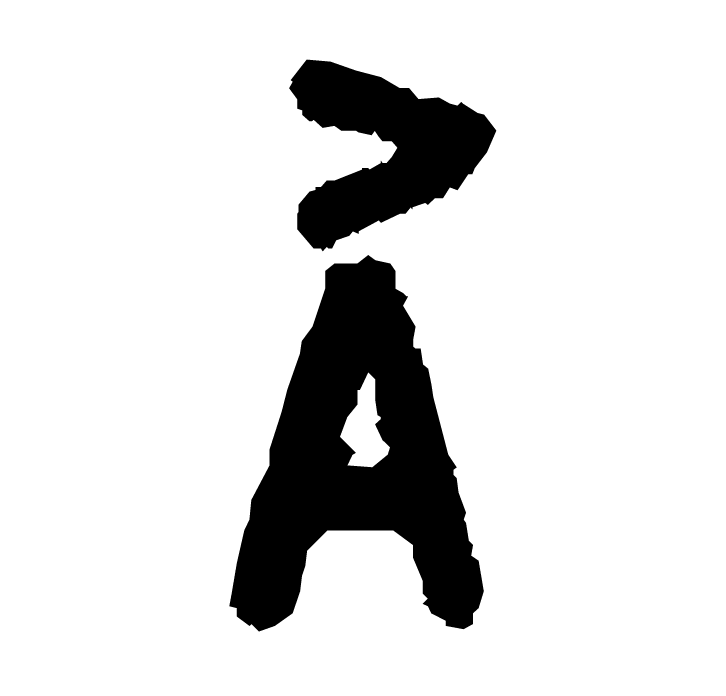
Testo precedente Testo successivo